Le BASILICHE PAPALI MAGGIORI sono QUATTRO
e si trovano a ROMA:
SAN GIOVANNI IN LATERANO
SAN PIETRO IN VATICANO
VIDEO MAPPING "SEGUIMI. LA VITA DI PIETRO"
SAN PAOLO FUORI LE MURA
SANTA MARIA MAGGIORE
Le BASILICHE PAPALI MINORI sono DUE
e si trovano ad ASSISI:
SAN FRANCESCO
SANTA MARIA DEGLI ANGELI
(PORZIUNCOLA)
I PATRONI D'EUROPA
Tra il VI e il VII secolo lo sviluppo del monachesimo favorì la definizione della liturgia dell'Ufficio
delle ore. Nel Medioevo, infatti, la vita del monaco alternava la preghiera al lavoro ed era suddivisa in
otto appuntamenti di preghiera: mattutino (prima dell'alba); laudi (dopo l'alba); ora prima (alle 6 del
mattino); terza (ore 9); sesta (ore 12); nona (ore 15); vespri (ore 17) e compieta (ore 20). Durante questi
momenti di preghiera i monaci intonavano salmi, inni, responsori (canti in cui al verso intonato dal
celebrante risponde
un ritornello corale).
Parallelamente si vennero fissando i periodi dell'anno liturgico (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua,
Ascensione, Pentecoste) e la liturgia musicale della messa. Quest'ultima comprendeva la serie di canti
del Proprio della messa (Introito, Graduale, Alleluia, Tratto, Offertorio, Comunione), i cui testi
variavano a seconda del periodo liturgico, e i canti (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Benedictus, Agnus
Dei), con testi che non variavano durante l'anno liturgico.
GREGORIO
MAGNO E LA NASCITA DEL CANTO GREGORIANO
Secondo la tradizione papa Gregorio Magno, alla fine del 6° secolo, riformò la liturgia della Chiesa
romana e raccolse le melodie che da lui prendono il nome. In realtà il canto gregoriano nacque
dall'opera di unificazione di varie tradizioni avviata tra l'VIII e il IX secolo in Francia dai re carolingi
Pipino il Breve e Carlomagno. Con il Sacro Romano Impero si determinò infatti una fusione tra il
canto
cristiano praticato in Francia, detto gallicano, e quello romano. Tale fusione diede vita al canto
gregoriano, diffusosi poi in Europa occidentale e rientrato a Roma con le discese degli imperatori
Ottoni (nella
seconda metà del 10° secolo).
Tra le fondamentali trasformazioni avvenute in età carolingia va ricordata inoltre la nascita della
scrittura musicale neumatica (dal greco nèuma "segno"), che servì a fissare per iscritto i canti che in
precedenza si tramandavano
oralmente.
Nel corso del IX e X secolo, l'esigenza di arricchire i testi e le melodie dei canti portò allo sviluppo di f
orme poetico-musicali indipendenti e perfino a drammatizzazioni di passi del Vangelo, rispettivamente
denominate tropi, sequenze e drammi liturgici.
Il canto gregoriano era il maggior rappresentante della musica religiosa della prima parte
del Medioevo, prima di esso, però vi era il canto cristiano.
Quest’ultimo si fondava su testi biblici e somigliava molto alla lingua parlata. Poi dal IV
secolo vennero introdotte nuove formule melodiche e nuovi testi e proprio in questo
periodo nacque l’inno, cioè testi e melodie di facile apprendimento, motivo per cui si
diffusero rapidamente.
Nel frattempo, in Occidente si erano formate tradizioni liturgiche locali e il canto
religioso aveva subito dei mutamenti. A Roma la musica era influenzata da quella greca
ed ebraica, ed il papa Gregorio Magno deciso di modificare lo stile della musica, di
riorganizzarlo, e così nacque il canto gregoriano che appunto prese il nome da questo
papa. Il canto gregoriano si diffuse in tutto il mondo occidentale e si basava sulla
notazione
neumatica attraverso cui era più facile imparare a memoria le varie melodie.
Lo stile del canto gregoriano
Il latino era alla base dei testi dei canti gregoriani, infatti era la lingua ufficiale della
chiesa, era monodico e quindi tutti i cantori intonavano su un’unica melodia come nel
coro
greco.
Si trattava di melodie semplici e davano l’impressione di una sorta di recitazione,
c’erano però altri casi in cui erano
più complessi, ricchi di note e di fioriture.
Guido d’Arezzo è famoso nel mondo per l’invenzione che ha rivoluzionato la storia della musica: la
notazione musicale. Sì, perché una cosa come il pentagramma, che oggi magari può sembrarci alla
portata di tutti, in realtà è un’invenzione
immensa, degna di un vero rivoluzionario.
L’inizio di
una grande rivoluzione culturale
Guido Monaco era nell’Abbazia di Pomposa (Ferrara) quando mise le basi per la musica scritta che
conosciamo oggi, ma il successo della sua invenzione gli si rivoltò contro. La rivoluzione culturale a
cui stava dando vita era una vera innovazione per il Medioevo, perché avrebbe portato la musica colta
fuori dalle abbazie,
rendendola alla portata di tutti.
Siamo nell’anno Mille quando il monaco benedettino e insegnante di musica inizia a sperimentare la
notazione sui canti gregoriani nelle Cattedrali di Arezzo e Pomposa. Giorno dopo giorno si rende
sempre più conto di quanto sia difficile per i monaci ricordare i tradizionali canti gregoriani e si ingegna
per aiutare
i suoi fratelli.
Certo, prima di lui un sistema di notazione c’era, quello neumatico, non basato su note musicali, ma su
neumi e melismi, cioè sulla trascrizione di una formula melodica e ritmica applicata ad ogni singola
sillaba. Il sistema era macchinoso e complesso da decifrare e gran parte dell’insegnamento e della
trasmissione
della musica era comunque legata a doppio filo con l’oralità.
Le sue innovazioni trovarono molte resistenze e per scappare da invidie e accuse si rifugiò ad Arezzo.
Ad accogliere Guido d’Arezzo a braccia aperte c’era la fiorente scuola di canto della Cattedrale con il
vescovo Tedaldo, pronto a dargli la sua protezione. Non è un caso che il Micrologus di Guido
d’Arezzo,
il
trattato e testo musicale più diffuso del Medioevo, fosse dedicato proprio a
Tedaldo.
Le note musicali, il tetragramma e la Mano Guidoniana
Partendo dalle prime sillabe dell’Inno a San Giovanni Battista di Paolo Diacono, cioè “Ut, Re, Mi, Fa,
Sol, La, Si”, Guido d’Arezzo ha dato i nomi alle note musicali. L’“Ut” sarà poi sostituito qualche
secolo
dopo con il Do da Giovanni
Battista Doni.
Ut queant laxis è l'inno liturgico dei Vespri della solennità della natività di San Giovanni Battista che ricorre
il 24 giugno.
La fama di questo inno, scritto dal monaco storico e poeta Paolo Diacono, si deve a Guido d'Arezzo, che
ne
utilizzò la prima strofa per trarne i nomi delle sei note musicali dell'esacordo:
| (LA) «Ut queant laxis | (IT) «Affinché possano cantare |
| (Inno a San Giovanni) | |
A ciascuna sillaba qui evidenziata corrisponde infatti, nella musica dell'inno, la relativa nota con cui è
cantata. Da tale criterio convenzionale derivarono i nomi delle note musicali Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La, con Ut
che, successivamente, venne sostituito da Do, sillaba che, terminando con una vocale, si pronuncia in
modo più agevole nel solfeggio.
Inoltre, ha codificato il modo di scrivere le note definendo le posizioni delle note su un grande rigo
musicale, proponendo un sistema unificato per la scrittura delle note. Per la parte terminale della nota
usava il simbolo di un quadrato, che
sarebbe poi diventato un rombo ed infine il nostro ovale.
Guido d’Arezzo introduce per la prima volta nella storia il grande rigo su cui indicare l’altezza delle
note a seconda del loro posizionamento, il tetragramma. A differenza del moderno pentagramma, che ha
cinque righe, il
tetragramma ne aveva quattro.
Sempre a Guido d’Arezzo si devono le invenzioni del sistema mnemonico della “mano guidoniana” per
aiutare l’esatta intonazione dei gradi della scala o esacordo e del sistema della solmisazione, una prima
forma di solfeggio. Queste invenzioni lo hanno reso famosissimo nel Medioevo, tanto da essere invitato
a Roma da Papa
Giovanni XIX.
Guido Monaco:
ad Arezzo la sua piazza e la sua statua
Arezzo ha dedicato a questo suo figlio illustre Piazza Guido Monaco con al centro la grande statua di
Guido d’Arezzo, inventore delle note musicali.
Nel monumento a Guido d’Arezzo, realizzato nel 1882 dallo scultore livornese Salvino Salvini, Guido
Monaco è raffigurato con la veste benedettina mentre posa la mano destra sull’antifonario contente la
strofa dell’Inno a San Giovanni da cui presero il
nome le note musicali.






una tappa storica importantissima;
Papa Francesco e il patriarca russo Kirill si sono















































































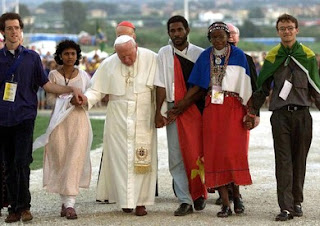




















































Nessun commento:
Posta un commento